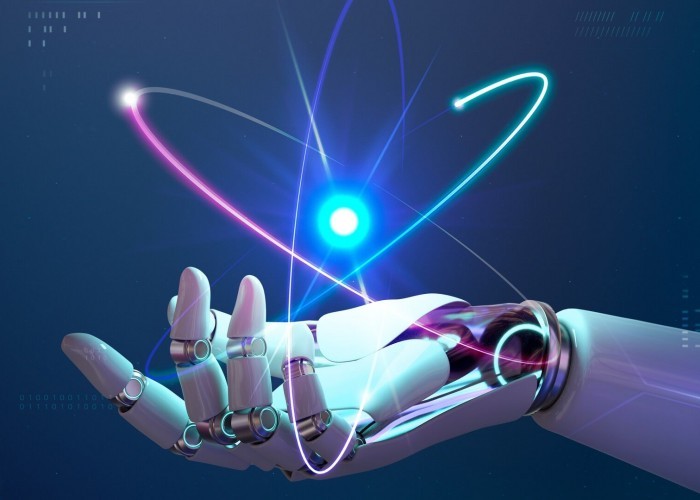La generazione di immagini con l’AI nello stile dello Studio d’animazione giapponese Ghibli sta rappresentando un imponente fenomeno di costume, accolto tuttavia anche da notevoli controversie nella tensione tra evoluzione dell’intelligenza artificiale e tutela del diritto d’autore.
Il termine “Ghiblification” è entrato nel linguaggio comune per indicare il principale fenomeno di costume esploso sul web nelle ultime settimane. Si riferisce alla generazione di immagini nello stile dello Studio Ghibli, attraverso una nuova funzione annunciata da OpenAi verso la fine di marzo. In breve tempo è sorta una moda globale che ha coinvolto anche account istituzionali, dando vita a una produzione sterminata di contenuti realizzati in uno stile fortemente riconoscibile e sollevando ulteriori interrogativi sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritto d’autore.
Per ottenere tale effetto, è sufficiente l’utilizzo di un prompt, ovvero un input testuale fornito all’AI (un semplice “ordine” o richiesta) per generare un output specifico. Peraltro, occorre precisare che nonostante l’estetica dell’acclamato studio d’animazione giapponese si sia imposta a livello di trend, la stessa funzione consente di realizzare immagini anche in altri stili d’animazione, come ad esempio quello, non meno noto, della Pixar.
Gli stili sono tutelati dal diritto d’autore?
Se una cifra estetica autoriale ha svolto un ruolo così caratterizzante nella diffusione di tale fenomeno di costume, è istintivo chiedersi se la stessa sia in qualche modo tutelata dal diritto d’autore.
Senza fare confusione con il diverso tema della tutela del design, occorre dare risposta negativa. Oggetto del diritto d’autore è infatti l’opera d’ingegno nella sua espressione formale. Non tratti stilistici, atmosfere o idee in sé, bensì la specifica espressione attraverso la quale trova manifestazione creativa l’idea che sta dietro l’opera. Pertanto, la stessa idea può trovare forma e realizzazione in opere diverse, da considerarsi tali in quanto esplicative di diverse creatività soggettive di ciascun autore (e pertanto ciascuna meritevole di tutela).
L’addestramento dei sistemi di AI generativa
Dunque, al di là delle controversie etiche, che si legano anche alla più volte dichiarata ostilità di Hayao Miyazaki nei confronti dell’intelligenza artificiale, quali sono le principali questioni legali ad emergere?
Il principale punto di tensione tra AI e diritto d’autore attiene all’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale. Per funzionare, infatti, i modelli di AI necessitano di processi attraverso cui “imparare” da grandi quantità di dati per identificare schemi e offrire output utili. Da qui sorge la necessità di tutela dei dati e del copyright.
Le soluzioni offerte dal Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act)
L’AI Act disciplina in modo specifico anche la tutela della proprietà intellettuale, sancendo che i fornitori sono tenuti a conformarsi alla normativa europea in materia di diritto d’autore. In particolare, devono garantire il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 3, della Direttiva (UE) 2019/790 (“Direttiva Copyright”), anche attraverso l’adozione delle più avanzate tecnologie disponibili. Questa norma riconosce ai titolari dei diritti la possibilità di riservare espressamente l’uso delle proprie opere e dei materiali protetti, escludendoli quindi dalle operazioni di estrazione automatizzata di testo e dati. Tale prerogativa, nota come “diritto di opt-out”, consente ai detentori dei diritti di limitare l’utilizzo delle proprie creazioni nell’ambito delle attività di text and data mining.
La tutelabilità delle opere realizzate con l’ausilio di AI
Diversa questione è la tutelabilità di opere d’ingegno realizzate (anche) attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Per dottrina e giurisprudenza è infatti indiscusso che l’AI possa fungere da mero strumento per la realizzazione dell’opera d’ingegno: pertanto di per sé non si può affatto escludere dalla tutela del diritto d’autore un’opera realizzata attraverso tali modalità tecniche. Piuttosto, l’apporto creativo umano andrà indagato in questi casi con maggior rigore, come affermato anche in Italia dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1107 del 2023.
L’esperienza della tutela delle opere fotografiche
D’altra parte, si tratta di un tipo di valutazione non del tutto diversa da esperienze già ben note alla giurisprudenza: pensiamo, per esempio alla distinzione tra fotografia e “opera fotografica”. Nonostante si tratti di uno scrutinio per nulla agevole e spesso arbitrario (che infatti ha trovato soluzioni contrastanti in giurisprudenza) è evidente che una fotografia scattata in modalità del tutto automatizzate e indipendenti da un apporto creativo, come quella di un autovelox, non potrà essere considerata un’opera d’ingegno, mentre certamente lo sarà un ritratto particolarmente curato dal quale emerga chiaramente la personalità del fotografo. Eppure, anche nel caso della fotografia ci si trova di fronte a un input umano e a un output meccanico.
Una questione ancora aperta
Al netto delle polemiche e di qualche malfunzionamento causato anche dallo stesso “boom” di richieste a “Chat GPT”, la questione occuperà spazio nel dibattito pubblico ancora per diverso tempo. I colossi dell’AI nordamericana stanno infatti agendo specifiche pressioni nei confronti del governo USA per far rientare l’addestramento dell’AI nel c.d. “fair use”, istituto che consente l’utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore per scopi d'informazione, critica o insegnamento, senza chiedere l'autorizzazione scritta a chi detiene i diritti.
Nel mondo globalizzato, caratterizzato da sfide comuni, le soluzioni sono interdipendenti. Anche per questo, occorrerà osservare le eventuali evoluzioni di disciplina negli USA e le esternalità (sostanziali prima che giuridiche) che potranno riversare sul resto del mondo.