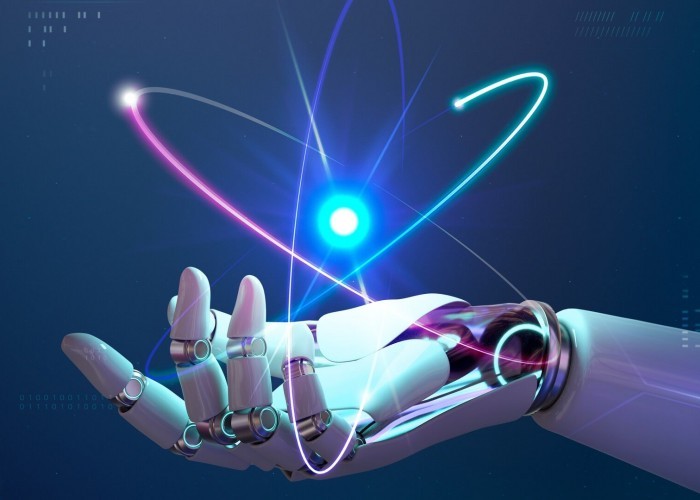Con l’ordinanza n. 7642, pubblicata in data 22 marzo 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione del criterio utilizzabile per la verifica delle soglie dimensionali fissate ex lege, il cui congiunto superamento rileva al fine della declaratoria del fallimento (oggi, liquidazione giudiziale) dell’impresa debitrice.
Secondo i Giudici di legittimità “[a]i fini della verifica di sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ciò che conta è la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile, con la conseguente possibilità di avvalersi dell’intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d’impresa di cui all’art. 2220 c.c.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultare utile”.
Il Codice della crisi d’impresa ha introdotto, sul piano definitorio, la nozione di “impresa minore”, intendendosi tale “l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila” (art. 2, co. 1, lett. d, Codice della crisi).
I requisiti dimensionali individuati dal Codice della crisi d’impresa, il cui congiunto superamento legittima l’assoggettabilità del debitore alla liquidazione giudiziale, corrispondono ai presupposti per la fallibilità previsti dalla Legge fallimentare (cfr. art. 1, co. 2, Legge fallimentare). L’unica differenza consiste nell’eliminazione dell’aggettivo “lordi”, utilizzato dalla Legge fallimentare per qualificare i ricavi, con conseguente rinvio alla disciplina codicistica prevista dagli articoli 2425 (“Contenuto del conto economico”) e 2425-bis (“Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri”) cod. civ. per l’individuazione di tale requisito.
Con specifico riferimento alla soglia dimensionale di indebitamento e alla necessità o meno che l’indebitamento risulti dalla contabilità dell’impresa al momento della dichiarazione di fallimento (oggi, liquidazione giudiziale) i Giudici di legittimità hanno chiarito - in sede di esame del disposto dell’art. 1, co. 2, Legge fallimentare - che “la contabilità deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendo tutti i documenti che riguardano l’impresa e che così incidono sulla sua situazione contabile-finanziaria. D’altra parte, l’art. 1 lett. c) cit. non prevede in alcun modo, affinché l’indebitamento superiore ai 500 mila euro rilevi quale requisito di fallibilità, che esso risulti dalla contabilità dell’impresa al momento della dichiarazione di fallimento. Inoltre, la stessa lett. b), relativamente ai ricavi lordi, nel far riferimento ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, neppure richiede che essi risultino necessariamente dalla contabilità, essendo, a tal fine, significativa l’espressione “in qualunque modo risulti””.