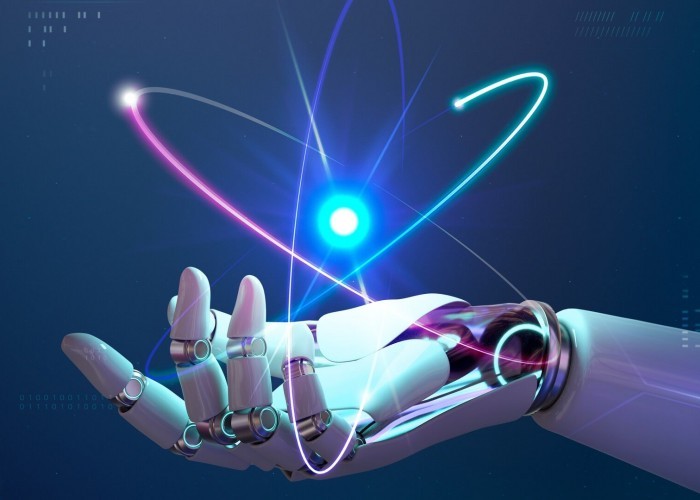L’eccezione di libera utilizzazione “a scopo di pastiche” rappresenta uno degli istituti di più difficile interpretazione nella disciplina del diritto d’autore. A fronte di una giurisprudenza nazionale scarna e oscillante, il recentissimo Parere dell’Avvocato Generale Emiliou offre alcuni spunti interpretativi meritevoli di osservazione.
L’eccezione del pastiche rappresenta uno degli istituti più dibattuti nella disciplina eurounitaria del diritto d’autore. Citato dalla Direttiva InfoSoc del 2001, nonché nella Direttiva Copyright (2019/790), il pastiche viene introdotto a completamento di un “trittico” che comprende anche la parodia e la caricatura. La sua autonomia rispetto a tali ultime due figure è stata oggetto di differenti interpretazioni, a fronte di una giurisprudenza ancora scarna. Di seguito ne ripercorriamo rapidamente l’evoluzione normativa, le poche pronunce giudiziarie europee e – in chiusura – le conclusioni dell’Avvocato Generale Emiliou, di recente depositate davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Le eccezioni di libera utilizzazione nel diritto d’autore
Un piccolo passo indietro per non dare nulla di scontato. Come noto, quando ci si trova dinnanzi a un’opera d’ingegno coperta dal diritto d’autore, in via generale qualsiasi utilizzazione della stessa deve essere autorizzata dall’autore o in ogni caso da chi detenga i diritti patrimoniali sulla stessa. Tuttavia, esistono alcune eccezioni, dette di “libera utilizzazione” che consentono per l’appunto l’utilizzazione per alcune finalità specifiche e predeterminate. Si pensi ad esempio all’art. 70 Lda, che menziona l’uso a fini di “critica e di discussione” o ancora i fini di “insegnamento e ricerca scientifica”.
Nella Direttiva InfoSoc: un’eccezione “facoltativa” per gli Stati Membri
Tali eccezioni hanno trovato una disciplina specifica riferita all’ambiente digitale già con la Direttiva “InfoSoc” (Dir. 2001/29/CE). In particolare, l’art. 5, par. 3, lettera k), di tale direttiva ha previsto una limitata categoria di eccezioni facoltative – tra le quali, quelle “per scopi di caricatura, parodia o pastiche” – lasciando però ai singoli Stati membri il compito di trasporre nel diritto interno tali disposizioni. L’eccezione, pertanto, era definita in termini assai generici, senza alcuna indicazione interpretativa sul suo perimetro e soprattutto senza alcun chiarimento sulle differenze rispetto alla parodia.
In concreto, fino al 2019 il pastiche è stato spesso ignorato dai legislatori nazionali, che hanno concentrato l’attenzione più sulla parodia. Di conseguenza, è mancata generalmente negli ordinamenti europei una specifica disciplina del pastiche, lasciando a giuristi e giudici il difficile compito di distinguerlo, caso per caso, dall’uso trasformativo più “satirico” o critico.
Il nuovo riconoscimento nella Direttiva Copyright
Un ulteriore, più importante, riconoscimento è avvenuto con la Direttiva (UE) 2019/790, nota come “Direttiva Copyright”. In primo luogo, il Considerando 70 cita il pastiche in una rassegna di libere utilizzazioni; l’art. 17(7) sancisce quanto segue: “Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti in ogni Stato membro possano avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni esistenti quando caricano e mettono a disposizione contenuti generati dagli utenti tramite i servizi di condivisione di contenuti online: a) citazione, critica, rassegna; b) utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche”.
Per gli Stati membri il pastiche diventa dunque un’eccezione obbligatoria, non più facoltativa. Ciò vale per i “contenuti generati dagli utenti tramite i servizi di condivisione di contenuti online” (si pensi alle più note piattaforme quali YouTube e Instagram). Alcuni osservatori avevano immediatamente interpretato tale eccezione come una apertura ai “meme”, diffusissimi online e che non sempre presentano contenuti caricaturali e parodistici.
Una giurisprudenza ancora scarna
Nonostante l’apparato normativo, le pronunce europee sul pastiche restano al momento piuttosto scarne e frammentarie. Le incertezze maggiori riguardano:
- Il contenuto minimo necessario per fare valere il pastiche: quanto “deve” richiamare l’opera originaria per potersi considerare un omaggio stilistico e non un uso illecito?
- Il confine con il fair use: pur non disciplinato in Europa, si tratta di una nozione dell’ordinamento statunitense spesso evocata rispetto a una interpretazione estesa del pastiche. In altri termini, il rischio di una nozione troppo ampia di pastiche sarebbe quello di far entrare “dalla finestra” il fair use anche negli ordinamenti eurounitari.
Le varie Corti nazionali hanno dunque oscillato tra una considerazione del pastiche come ramo autonomo dell’eccezione per parodia, altre volte trattandolo come una mera citazione “rafforzata”.
Le conclusioni dell’Avvocato Generale Emiliou
È in questo contesto di incertezza che si inserisce la recentissima opinion dell’Avvocato Generale Emiliou (Procura Generale presso il CJEU) nel procedimento C-590/23 (cd. “Pelham II”). L’AG Emiliou ha affrontato il tema del campionamento musicale e dell’eccezione del pastiche, tracciando alcuni paletti fondamentali:
- Autonomia dell’istituto: il pastiche è da considerarsi un’eccezione distinta dalla parodia, dotata di propria ragion d’essere e non subordinata a intenti satirici o critici.
- Natura formale: ciò che rileva è l’imitazione dello “stile” o del “linguaggio estetico” dell’opera originale, purché integrata in un contesto diverso e senza riproduzione integrale di parti protette.
- Three-step test: ogni invocazione del pastiche deve rispettare il “test” di bilanciamento previsto dall’art. 5(5) della Direttiva InfoSoc (anche se ancor più risalente). Deve dunque trattarsi di un’eccezione prevista per casi specifici e particolari, senza pregiudicare il normale utilizzo dell’opera e senza ingiustificato pregiudizio agli interessi del titolare dei diritti.
- Integrazione nella disciplina del campionamento: nel caso di opere sonore, il pastiche dovrebbe consentire solo quella parte di “estratto” adeguata allo scopo imitativo, purché non eccedente rispetto a quanto necessario per evocare lo stile.
Questioni di stile
Un passaggio importante torna poi su un tema recentemente dibattuto in materia di diritto d’autore (in partcolare dopo il “caso Ghibli”): il ruolo dello “stile” nella tutela del diritto d’autore. Sebbene gli stili in generale non possano essere protetti perché rappresentano un’idea più che una specifica espressione (e il copyright tutela le specifiche espressioni di un’opera: non l’idea che le regge) diverso è il caso in cui qualcuno “imita da vicino lo stile di una singola opera. Gli elementi presi in prestito, pur essendo ‘stilistici’, possono ancora essere considerati originali, soprattutto se combinati”. Il pastiche potrebbe dunque consistere in una legittima “presa in prestito” stilistica, in particolare in ambito musicale, in cui l’intento imitativo sia evidente o addirittura dichiarato, tanto che risulti riconoscibile anche il lavoro imitato.
L’importanza che il pastiche non si traduca in una nozione “pigliatutto”
In conclusione, viene difesa l’dea che la nozione di pastiche non diventi una nozione “catch-all” applicabile a tutte le espressioni derivate, anche perché un'interpretazione di questo tipo comprometterebbe l'equo equilibrio stabilito dal legislatore dell'UE che prevede specifiche forme di libera utilizzazione. Pur nelle evidenti difficoltà interpretative, far leva sulla indefinitezza del pastiche per renderlo un “refugium peccatorum” volto ad accogliere ogni anche sì veniale lesione del diritto d’autore rappresenterebbe non solo una soluzione teoricamente scorretta ma una falla nella stessa applicazione della disciplina.