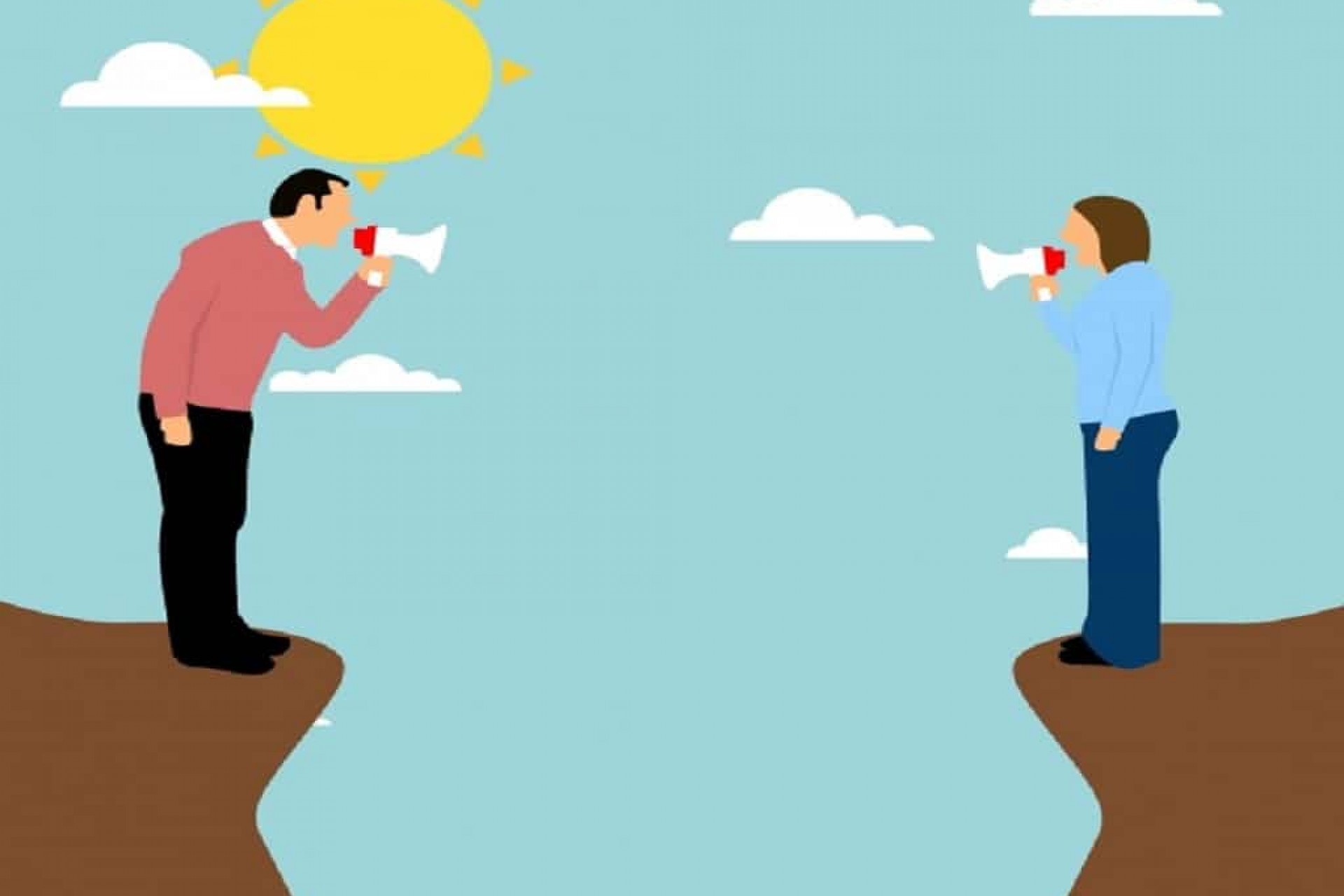
Con la sentenza 11 maggio 2018, n. 21133, la Corte di Cassazione ha avuto modo di riaffermare un principio ormai consolidato in tema di diffamazione.
In particolare, pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di merito aveva confermato la condanna per il reato di diffamazione nei confronti del dipendente di una residenza sanitaria, che aveva offeso i titolari-datori di lavoro, definendoli “banditi”, la Suprema Corte – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente i giudici avrebbero desunto il dolo del reato di cui all’art. 595 c.p., solo dal termine "banditi" adoperato, senza tuttavia rendersi conto della non ricorrenza dell’intento diffamatorio, anche per la genericità dello stesso – ha diversamente argomentato che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l"animus iniurandi vel diffamandi", essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente.
Avv. Flaviano Sanzari


