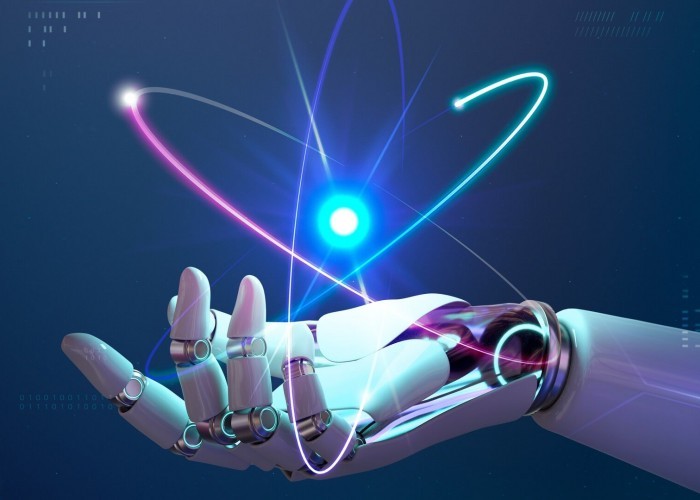Con una recente sentenza del 27 aprile la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-686/21) si è pronunciata sulla richiesta di pronuncia pregiudiziale della Corte di Cassazione sulle “questioni di interpretazione del diritto comunitario” relativamente alle “modalità di esercizio individuale del diritto esclusivo detenuto congiuntamente dai contitolari di un marchio”.
Prima di entrare nel cuore di quanto deciso dalla Corte di Giustizia, facciamo un passo indietro per analizzare per sommi capi i fatti di causa che hanno necessitato la rimessione della questione in sede europea.
I fatti di causa
Nel 1993 quattro contitolari di alcuni marchi concedevano unanimemente alla società Legea “una licenza esclusiva, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, sull’uso dei marchi”; successivamente, nel 2006 uno dei licenzianti contitolari revocava il proprio consenso alla prosecuzione della licenza. Qualche anno più tardi, la società licenziataria citava in giudizio avanti al Tribunale di Napoli il licenziante dissenziente per fare dichiarare ex multis la nullità dei marchi (nazionali, internazionali e comunitari) contenenti il segno “Legea” registrati dal convenuto; quest’ultimo resisteva con domanda riconvenzionale chiedendo a sua volta, tra le altre, la declaratoria della nullità dei marchi registrati dalla società attrice e della illiceità dell’uso dei marchi in questione. Tanto premesso, il giudice di prime cure giudicava che l’uso dei marchi da parte della società attrice fosse da considerarsi lecito fino alla data di revoca del consenso alla prosecuzione del contratto di licenza; a partire da tale data, in mancanza del consenso unanime dei contitolari alla prosecuzione del rapporto, l’uso era invece da ritenersi illecito.
Di contraria opinione era la Corte d’Appello partenopea: non era, infatti, necessario il consenso unanime dei contitolari alla prosecuzione del contratto di licenza, bastando piuttosto la volontà concorde di tre contitolari su quattro alla prosecuzione del rapporto per rendere lecito l’uso dei marchi da parte della società.
Investita delle impugnazioni avverso la sentenza di appello, secondo la Corte di Cassazione la questione prospettata atteneva alla comunione sul marchio a livello europeo, che, sebbene ammessa, non conteneva “riferimenti idonei a regolare le modalità di esercizio dei diritti di comunione”. La Corte decideva, quindi, di sospendere il giudizio e preliminarmente interrogare la CGUE: per concludere o recedere da un contratto di licenza di marchio in comproprietà serve, dunque, l’unanimità o basta la maggioranza?
L’iter della Corte di Giustizia
Il marchio dell’Unione europea – introdotto come marchio comunitario con il regolamento (CE) 40/94, da ultimo sostituito col regolamento (UE) 2017/1001 – si qualifica come marchio a carattere unitario, produttivo dei medesimi effetti in tutta l’Unione europea. Nel decidere la questione, preliminarmente la Corte di Giustizia fornisce appunto una panoramica dell’evoluzione normativa a livello europeo giungendo ad affermare che, in ragione del periodo di svolgimento dei fatti di causa, la questione debba essere valutata, per quanto riguarda i marchi UE, ai sensi del regolamento (CE) 40/94 e, per quanto riguarda i marchi nazionali, ai sensi della direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa. In particolare, con lo sguardo rivolto alla normativa regolamentare, la Corte individua negli articoli 16 e 21 del regolamento (CE) 40/94 (corrispondenti agli attuali artt. 19 e 24 del regolamento (UE) 2017/1001) la fonte espressa del diritto di contitolarità sul marchio UE, riconoscendo altresì a livello regolamentare la carenza di “disposizioni (…) che disciplinino le modalità di adozione, da parte dei contitolari di un marchio dell’Unione europea, della decisione di concedere una licenza d’uso di quest’ultimo o di recedere dal relativo contratto”. A simili conclusioni giunge anche analizzando la direttiva 89/104/CEE, rispetto alla quale rileva come la stessa, addirittura pur non “fa(cendo) riferimento alla comproprietà di un marchio nazionale”, non ne esclude la relativa esistenza, ma semplicemente ne rimette la disciplina al diritto nazionale, con tutte le relative conseguenze anche in termini di modalità di esercizio dei diritti conferiti dal marchio; è, infatti, vero – prosegue la Corte – che sebbene lo scopo del Legislatore comunitario sia stato il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, la direttiva “non mira a un ravvicinamento completo di tali legislazioni”. Conclusione questa che, unitamente alle osservazioni in tema di regolamento, lascia intravedere la decisione della Corte.
La decisione della Corte di Giustizia
È, infatti, vero – prosegue la Corte – che il regolamento (CE) 40/94 riconosce la comproprietà di un marchio dell’Unione europea, ma è vero anche che, in assenza di disposizioni che ne disciplinano le modalità di adozione delle scelte relative alla conclusione di contratti di licenza e/o al recesso dagli stessi, “dette modalità sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro”.
La Corte di Giustizia non ha dubbi e la questione se la concessione di una licenza o il relativo recesso debbano essere soggette alla decisione unanime o a maggioranza dei comproprietari del marchio “dev’essere risolta in base al diritto nazionale applicabile”.