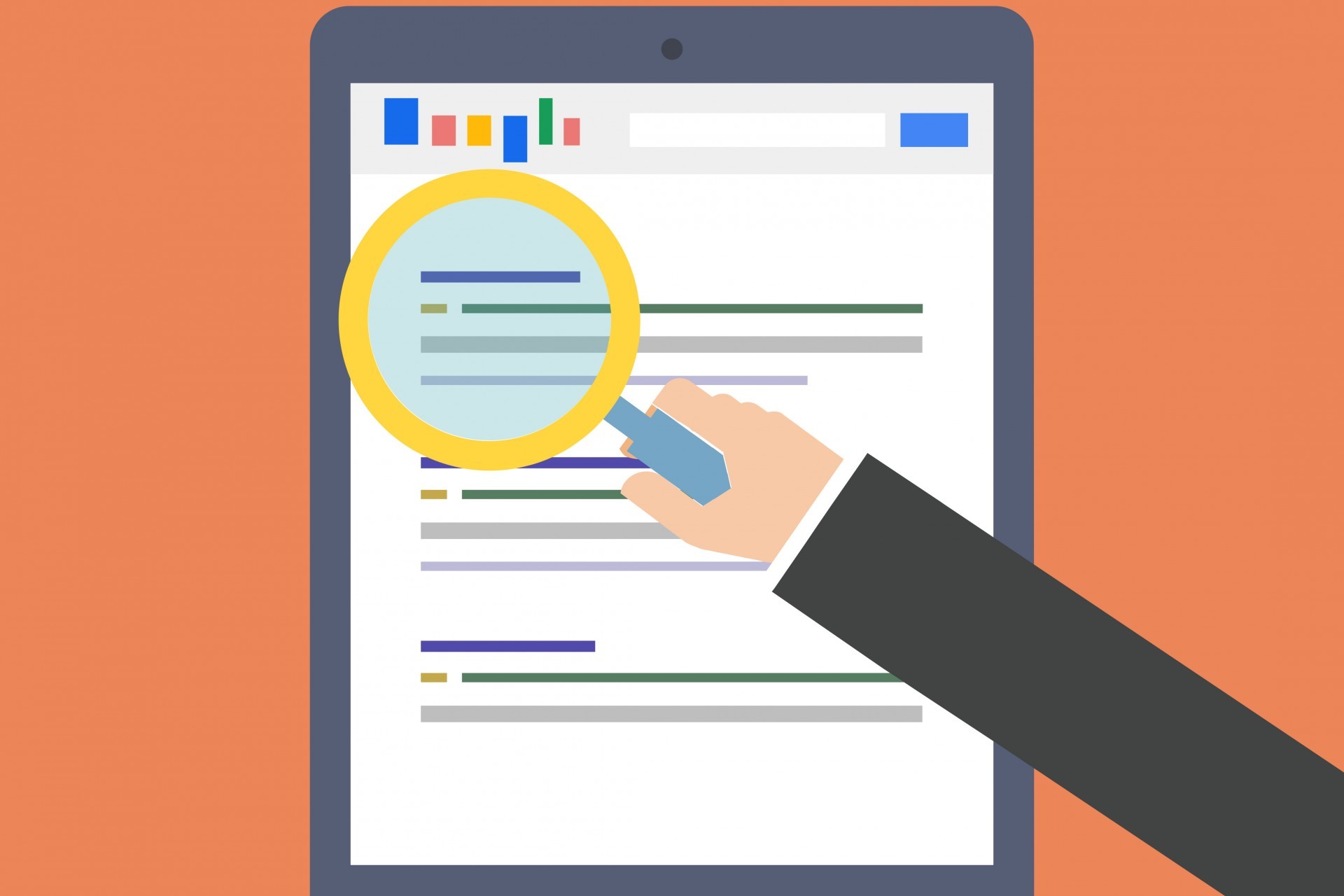
Lo scorso 8 giugno, con ordinanza n. 18430/2022, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da Google LLC avverso la sentenza n. 4911/2019 del Tribunale di Milano, a seguito della quale il colosso americano era stato condannato alla deindicizzazione di una serie di URL recanti contenuti diffamatori, alla cancellazione delle tracce digitali di tale ricerca, nonché al risarcimento dei danni morali patiti dall’interessato a seguito della permanenza dei suddetti contenuti.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla diffusione in internet, da parte di un collega di lavoro del soggetto leso, di affermazioni mendaci circa l’appartenenza di un parente di quest’ultimo ad un’associazione di stampo mafioso. La menzionata condotta, in sede penale, era stata censurata dal Tribunale di Lecco, che aveva condannato il “collega” per diffamazione.
L’attore aveva quindi richiesto a Google la deindicizzazione degli indirizzi URL recanti i predetti contenuti ma, stante l’inerzia del noto motore di ricerca ed il conseguente perdurare della situazione de quo, rivolgeva le proprie istanze al Tribunale di Milano.
La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Milano, investito della questione, oltre a riconoscere la sussistenza della ricostruzione attorea:
- ha ritenuto inapplicabile la disciplina di cui al D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, assumendo che la responsabilità di Google dovesse ricondursi alla clausola generale dell’art. 2043 c.c., non sussistendo, in più, alcuna limitazione di responsabilità giacché la convenuta abbina soggetti e siti secondo una propria scelta, rendendo disponibili informazioni aggregate, con un valore aggiunto autonomo rispetto a quello offerto dai siti sorgente;
- operato il necessario bilanciamento tra gli interessi in gioco (alla libertà economica ed alla manifestazione del pensiero, da un lato, ed all’identità personale, onore e reputazione, dall’altro), ha ravvisato l’illiceità del trattamento effettuato da Google - almeno dal momento in cui a quest’ultima è pervenuta una diffida comprensiva della succitata sentenza penale.
Conclusivamente, il Tribunale ha, quindi, ritenuto di includere, oltre agli indirizzi indicati dall’istante e quelli relativi alla precedente condanna idonei a rievocare la vicenda, anche quelli riferibili a siti gestiti da altri motori di ricerca, in quanto Google, attraverso un’attività di organizzazione e indicizzazione di testi, mette a disposizione degli utenti i riferimenti necessari per identificarli.
L’interpretazione della Suprema Corte
Avverso la predetta sentenza, Google ha promosso ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi; di seguito, si analizzeranno sinteticamente i principali.
Si evidenzia, in primo luogo, come la Suprema Corte, rigettando il primo dei motivi di ricorso (incentrato sull’asserita indeterminatezza circa quali URL dovessero essere deindicizzati), ha ritenuto che la tecnica redazionale della motivazione della sentenza impugnata, pur non corrispondendo alla migliore possibile ed ai precetti di massima chiarezza e completezza, non si pone al di sotto del livello minimo costituzionale, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione di norme, assumendo, principalmente, che il Tribunale avesse confuso le figure di hosting e cashing provider, quest’ultimo essendo il ruolo attribuibile a Google.
Tale motivo è stato ritenuto in parte inammissibile dai giudici di legittimità - poiché ripropositivo di un giudizio sul fatto (quello vertente sulla qualifica di hosting e/o caching provider attribuibile a Google) - ed in parte infondato sotto il profilo giuridico. Sotto quest’ultimo aspetto, la Corte ha ravvisato che, avendo la sentenza impugnata ritenuto la ricorrente un hosting provider, non vi è ragione per discostarsi dal principio – già affermato dagli Ermellini – per cui “il prestatore del servizio di hosting è responsabile … quando: a) egli “sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita” e per quanto attiene ad azioni risarcitorie “sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione”; oppure b) egli non “agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso” appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti” (cfr. Cass. Civ. n. 7708/2019).
Da tale premessa discende che, per quanto la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto inapplicabili le previsioni di cui al D. Lgs. 70/2003, il motivo di ricorso va sul punto comunque disatteso, risultando il decisum conforme a diritto (ex art. 384, c IV, c.p.c.).
Avv. Pietro Maria Mascolo e Dott. Lorenzo Pinci


